
Vi è mai capitato di rimandare un compito, pur sapendo che prima o poi dovrete affrontarlo? Magari avete detto a voi stessi: “Lo faccio dopo”, “mi serve l’ispirazione giusta”, “non ho abbastanza tempo ora”. Eppure, dentro di voi lo sapete bene: più si rimanda, più cresce il senso di disagio e frustrazione. Questo è il cuore della procrastinazione: il comportamento volontario di posticipare attività che sappiamo essere importanti, spesso senza una reale giustificazione logica.
A differenza della semplice disorganizzazione, la procrastinazione coinvolge una lotta interna tra ciò che sappiamo di dover fare e ciò che preferiamo fare nell’immediato (Klingsieck, 2013). Questo fenomeno è estremamente diffuso, tre dati a supporto:
- 50% degli studenti procrastina in modo regolare (Day, Mensink & O’Sullivan, 2000);
- 20% degli adulti si definisce procrastinatore abituale (Steel & Ferrari, 2012);
- È leggermente più frequente negli uomini e tende a ridursi con l’età.
La domanda sorge spontanea: quali sono le vere cause della procrastinazione? E soprattutto, come possiamo contrastarla?
Le cause della procrastinazione
La procrastinazione è il risultato di diversi fattori psicologici e motivazionali.
Ecco le principali cause:
1. Il bisogno di gratificazione immediata
Rimandiamo le attività perché il nostro cervello preferisce ricompense a breve termine (guardare Netflix, scorrere i social, fare un aperitivo con gli amici) piuttosto che uno sforzo che porterà benefici solo in futuro (Steel, 2007).
2. La percezione del compito come sgradevole
Se un’attività è noiosa, complessa o stressante, tendiamo a rimandarla per ridurre l’ansia nell’immediato, anche se questo aumenta lo stress a lungo termine.
3. Tratti di personalità e impulsività
Alcune caratteristiche psicologiche favoriscono la procrastinazione:
- Basso livello di coscienziosità → meno capacità di pianificare e seguire le scadenze;
- Alto livello di nevroticismo → ansia e insicurezza che bloccano l’azione;
- Sensation seeking → preferenza per attività stimolanti rispetto a compiti più monotoni (Steel, 2007).
4. Bassa autoefficacia e perfezionismo
- Se pensiamo di non essere capaci di completare un compito, tenderemo a evitarlo (Bandura, 1997).
- Il perfezionismo eccessivo porta a pensieri come “Non sarà mai abbastanza buono”, aumentando il rischio di blocco (Rozental & Carlbring, 2014).
5. L’autosabotaggio
A volte procrastiniamo per proteggere la nostra autostima: se rimandiamo fino all’ultimo minuto, possiamo giustificare un eventuale fallimento con la mancanza di tempo, invece che con le nostre capacità (Burka & Yuen, 2008).
Insomma dobbiamo hackerare il nostro cervello.
La scienza della procrastinazione: la teoria della motivazione temporale
Secondo la Temporal Motivation Theory (Gröpel & Steel, 2008), la procrastinazione è influenzata da quattro fattori:
(Aspettativa × Valore) / (Impulsività × Tempo necessario)
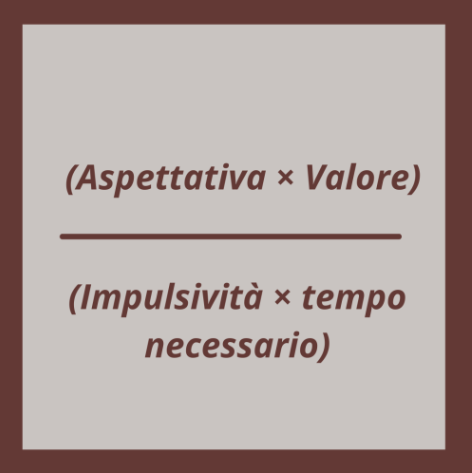
- Aspettativa → Se crediamo di poter riuscire, agiremo più rapidamente.
- Valore → Se percepiamo un compito come utile o significativo, saremo più motivati.
- Impulsività → Più siamo inclini a distrarci, più sarà difficile iniziare.
- Tempo necessario → Più tempo richiede un’attività, più tenderemo a sottostimarlo e rimandare.
Quando l’aspettativa di riuscita e il valore sono bassi, e l’impulsività e il tempo richiesto sono alti, la procrastinazione aumenta.
Come smettere di procrastinare: strategie pratiche
Ecco alcune tecniche basate sulla ricerca scientifica per ridurre la procrastinazione e aumentare la motivazione:
1. Creare un ambiente senza distrazioni
- Disattivare notifiche e allontanare le tentazioni.
- Scegliere un luogo dedicato al lavoro, privo di interruzioni.
2. Usare la “Tecnica dei 5 Minuti”
L’idea è semplice: iniziate un’attività per soli 5 minuti. Spesso, il problema più grande è iniziare. Una volta avviati, sarà più facile continuare (Burka & Yuen, 2008).
3. Applicare la strategia del “Premack”
Associare un’attività meno piacevole a una gratificante: “Prima finisco questo report, poi posso guardare un episodio della mia serie preferita” (Premack, 1959).
4. Suddividere il compito in micro-obiettivi
- Trasformare un grande progetto in piccoli step;
- Usare checklist per monitorare i progressi;
- Celebrare ogni piccolo traguardo raggiunto.
5. Creare un piano d’azione dettagliato
- NO: “Scriverò la relazione”.
- SÌ: “Dalle 15 alle 15.30 organizzo i materiali, dalle 15.30 alle 16 stendo la scaletta, dalle 16 alle 16.30 scrivo la prima parte”.
6. Rafforzare la motivazione intrinseca
- Rinnovare il senso di ciò che si sta facendo.
- Collegare l’attività ai propri valori e obiettivi a lungo termine.
- Applicare la tecnica “If…Then” (Gollwitzer, 1999): “Se mi distraggo con il telefono, allora lo metto in un’altra stanza”.
Si, la procrastinazione si può superare!
Rimandare non è solo una questione di organizzazione, ma di neurobiologia, emozioni e motivazione. Modificare l’ambiente, le abitudini e il modo in cui percepiamo il compito può fare una grande differenza.
Il coaching dinamico, lavorando su motivazione e cambiamento, aiuta a individuare gli ostacoli dietro la procrastinazione e a costruire strategie personalizzate per aumentare la produttività senza stress.
Quale di queste strategie vi sembra più utile?

